-
.
SCUOLE FREQUENTATE
// | //
RAZZE E ABILITA
Genasi [Ibrido] | NO
Viaggiatore Naturale | NO
Veggente | 2020 | NO
PROFESSIONE
Informazioni/Viaggi Intedimensionali | Imperial - 2020/oraORGANIZZAZIONI E SETTE
// | //
FEDINA PENALE
// | //
IMMIGRAZIONE
Svedese | 1999 | Legale
Americana | 2020 | Legale
Cęriliāna | 1999 | Illegale
Al Sura | 2012 | Legalemind ⑇ body ⑇ timeline ⑇ curiosities ⑇ infonome Esålengræknüčak; Composto da Eså che nella mia lingua natale significa Aurora Polare, Lengræk che vuol dire guida o colui che guida, ha un significato doppio perché questa parola, nello specifico, non è usata sempre per le persone; Lengræk può essere un segno lasciato sulla terra, una stella, tanto quanto un uomo. Nüčak è la solutidune. Tiârastrįėlïshk, il mio secondo nome, è quello di mia madre. Si usava così, nel nostro popolo, dove sono sempre state le donne a guidare le famiglie e così, di madre in figlio e figlia, il nome viene passato da una generazione all'altra. Ma ho avuto molti altri nomi da quando mi hanno strappato alla mia famiglia. Ero Ath a Idur, la polvere bruciata del carbone. Sono stato Dėlïshk l'errante, il nomade, per i miei primi tempi a Hillaj e sono diventato così Al Sahi, colui che secondo le credenze di Al Sura ha donato le stelle al mondo per illuminare il sentiero dei viaggiatori. Sono stato Threlasan, il Freddo, a Yean Edhil. Ero Omen a Kirn Nardirth e sono diventato Minylath, il Caduto, quando mi sono lasciato Neurosis alle spalle. Ora sono solo Eså.
cognome Hölasdot-Varlas; Il primo, Hölasdot, è il segno della mia dinastia con Höla che la rappresenta e sdot che è "figlio". Varlas era il cognome di mio padre. Quello che uso qui, di cognome, è Åkerlund , del tutto fittizio e con il solo scopo di "integrarsi" a questa società.
titoli A'aq, è un titolo che ha valenza in pochissime Dimensioni. Al Sura è una di queste, ma anche a Yean Edhil qualcuno, sentendolo nominare o guardando il mio sigillo, ha saputo avere occhi diversi. A'aq è qualcuno che Viaggia nelle Dimensioni ma non solo. Le leggende di Al Sura dicono che gli A'aq sono dei messaggeri, dei profeti, persone che hanno uno scopo, e lo hanno fra i sentieri di tutti i mondi che sfiorano.
data di nascita 28 ottobre 1999
segno zodiacale non mi è mai importato di queste cose ma una volta, Saida Zayirah, ci parlò degli Astri delle Nascite di Al Sura e mi disse che il mio era Shiraji. Nella loro cultura ci sono 18 astri, e come per noi sono quelli che influenzano il cielo in determinati periodi dell'anno. Per loro ogni Astro rappresenta una figura della loro storia e mitologia, che a loro volta sono rappresentazioni. Shiraji era, nei loro racconti, un ragazzo che aveva perso i suoi ricordi dopo che per una scommessa con un'altra Divinità, Al Aduraq glieli aveva rubati. Nella notte, nei sogni, Adlaj che Sehlul gli avevano detto che li avrebbe trovati in un buco del cielo, poco oltre la stella Nileem, così Sharji vi si avventurò. La fase che rappresenta Shiraji è quella del sonno profetico, dell'attesa e della perseveranza. La storia era molto più lunga, e ricordo che Saida Zayirah la raccontava con piacere ogni volta che gliela chiedevo, ma il punto che mi disse una volta, una delle ultime in cui abbiamo parlato, è che Shiraji è il senso della ricerca e, mi disse, era appropriato a me che sapevo alzare gli occhi e cercare sempre.
razza sono per metà un Genasi di Ghiaccio. Mia madre Tiârastrįėlïshk mi ha tramandato questa essenza
abilità qui ci chiamano Viaggiatori Dimensionali, ad Al Sura eravamo Sehluwa, i Camminatori, e ho sentito tanti altri nomi. Ma io sono un A'aq, e risponderò sempre a questo.
ruolo penso che il mio scopo e il mio ruolo siano due cose diverse. Elmar Asad avrebbe detto così al mio posto. Lavoro all'Imperial, dove metto a disposizione le mie abilità di Viaggiatore per portare le persone da un punto all'altro del Multiverso, o dare informazioni su luoghi che conosco o a cui posso arrivare per reperire dati utili
allineamento quello che ho imparato nei miei viaggi, da tutti i Madin, è stato l'equilibrio. Ogni cosa ha il suo posto e il suo perché, c'è un bilancio perfetto in ogni parte dell'esistenza. Esiste l'armonia naturale che ogni sfumatura la fa unire e collidere una contro l'altra; c'è il fuoco che riscalda nelle notti come esiste quello che erutta da un vulcano; esiste la pioggia che nutre la terra così come quella che violenta sradica tutto. C'è l'equilibrio, ed è quello che va preservato sempre. Né troppa luce, né troppa ombra, Urjec lo diceva sempre. Hanno bisogno una dell'altra. [Neutrale Puro]
catalizzatore [+] Diaspro Rosso
Si affianca a quelle persone in cui è viva la voglia di lottare, non la determinazione di vincere ma la forza di combattere. Spesso maghi che possiedono il Diaspro Rosso sono quelli che non hanno ceduto ad una dominazione psicologica o fisica, o chi è uscito da un letargo della propria mente ritrovando vitalità e passione per ricominciare o andare avanti. La pietra dei resilienti.
[-] Turchese
La parte yang viene chiamata invece la Pietra delle Sfortune, perché al contrario del turchese chiaro quello oscuro attira in modo costante sul mago avventure o sfide lungo tutto il percorso turbolento portandolo a volte allo sfinimento. La strada per questi maghi sarà intricata, spesso complicata, ricca di agitazioni e confusione. Capita spesso che i portatori di Turchese oscuro siano fuggiaschi o ricercati. Hillaj la conservo ancora nei miei ricordi. Avrà sempre un posto speciale per me, per quelle volte che nel cielo sia Adlaj che Sehlul riempivano di luce pallida le sere più calde, specchiandosi nelle fontane della Piazza Alta e potevano finalmente ritrovarsi dopo essersi rincorse per così tanto. Era stata Saida Zayirah a raccontarmi la storia delle Lune e del loro sacrificio, di come due giovani si fossero strappati dalle strade e dalla stretta uno dell'alto per placare la furia di Al Aduraq. Ho visto così tanti posti quando ho lasciato Al Sura, ma nessuno saprà stringersi nel mio petto come quella città dai vicoli ripidi e stretti, i colori così accesi, gli odori di spezie e incensi a culminare dalla strada del mercato per avvolgere ogni mattone e pietra di un abbraccio tanto docile da sembrare quello di una madre protettiva che lecca cuccioli ancora troppo piccoli per tenersi sulle proprie zampe. Ma a Hillaj ci arrivai solo molto dopo l’vento che la mia vita l’ha cambiata per sempre. Quando avevo 10 anni mi hanno strappato via alla mia famiglia. La cosa che trovo spesso curiosa è che ho pochissime memorie di quell’evento preciso, ma riesco a ricordare benissimo tutto quello che accadde prima e tutto quello che venne dopo. Probabilmente in pochi conoscono l’esistenza di gruppi di persone che hanno la mia stessa capacità, quella di Viaggiare nelle Dimensioni, e che la usano per rapire persone e infilarle nel commercio degli schiavi. È una realtà che spesso al nome di tutti quegli scomparsi di cui non si ha più traccia, anche se non molti sanno come funziona. Io sì. Lo so perché è quello che mi è successo prima di arrivare a Hillaj. Erano stati A'aq Elmar Asad Al Luqtal e A'iya Saida Zayirah Al Luqtal a portarmi fuori da quel mondo cupo e doloroso e mi avevano preso a Idur, un posto che anche non dimenticherò, anche se vorrei. Ci ero arrivato ancora bambino, appena strappato dal calore dei miei genitori, e mi era stato detto, in quelle prime ore caotiche fra pezzi di metallo decadente, che non ero nessuno. Avevo smesso di esserlo non appena mi avevano stretto le braccia con i legacci per imprimermi quello che sarebbe stato il mio nuovo nome con un marchio di fuoco sulla pelle. Non ero più Esålengræknüčak Tiârastrįėlïshk Hölasdot-Varlas, avrei risposto al nome di Ath. Nella lingua di quei luoghi Ath è la polvere scura del carbone che viene masticato dalle braci, una sporcizia che si attacca alla pelle e l'annerisce, ed era facile vedere fra i vicoli di Idur uomini, donne e bambini con macchie tanto dense che alla fine cambiavano il pigmento della pelle. Ero stato fortunato, io, perché a prendermi al mercato degli schiavi non erano stati gli uomini delle fabbriche sputa fumo, ma una famiglia che viveva appena fuori dalla frenesia della città, in quelle case che venivano costruite da chi aveva molti soldi per star lontano dalla sporcizia delle fabbriche. Del marchio a fuoco sapevo che per loro privare qualcuno del suo nome era come privarlo di tutto, e per quanto non ci fosse nessuna magia a premere nella realtà quell'idea, da quando divenni Ath capii il profondo significato di quel concetto. Con i tempo divenni Ath, solo Ath. Un bambino come ce n'erano tanti in quella casa. Non potevamo parlare fra noi, era la regola degli schiavi, potevamo solo rispondere ai nostri padroni quando venivano direttamente interpellati, e dovevamo assicurarci di tenere sempre gli occhi bassi quando questo succedeva. Quando disobbedivamo, quando sbagliavamo, quando rompevamo qualcosa, i padroni potevano punirci e non mancavano di farlo. Ricordo che Inuck, quello che nella casa aveva il compito di gestire noi schiavi, quando mi puniva ripeteva sempre che serviva a far ricordare in ogni istante come funzionavano le cose lì a Idur. Era importante che nessuno degli schiavi si mettesse mai in testa di fare niente, lo capii solo un paio d'anni dopo, quando la famiglia in cui stavo perse ogni suo bene e iniziò a vendere schiavi per non andare in banca-rotta. Tornai al mercato e a comprarmi fu Omrad, uno dei proprietari delle fabbriche in città. C'era un lavoro specifico per cui servivano bambini piccoli o persone davvero minute, ed era quello di pulire i tubi di scarico che s'incrostavano, o l'interno dei forni del carbone. Anche lì gli schiavi non potevano parlare fra di loro, ma con tutte le persone che c'erano era molto più facile infrangere qualche regola e non esser scoperti. Lì incontrai Vez. Vez nella lingua di Idur è l'acqua piovana quando si sporca del nero delle strade e sembra quasi pece. Capii quanti schiavi ci fossero in quella città, molti più dei padroni, e compresi l'importanza delle punizioni e delle regole che ci impedivano di parlare fra noi. Se un giorno ad uno schiavo fosse venuta qualche strada idea sarebbe stato un problema e Idur, probabilmente, sarebbe crollata in pochi giorni. Ma a nessuno interessava, anche se non dovevo essere l'unico ad aver avuto quell'intuizione, e perfino Vez, che mi insegnò a come rubare del pane per avere qualcosa in più da mangiare ogni sera, non voleva saperne mai di sovvertire il potere. Avevamo corpi pieni di lividi e sporco, e sapevamo solo avere paura ogni volta che uno dei responsabili si avvicinava. In poco tempo divenni troppo grande per il mio lavoro e invece di farmi passare nelle miniere o alle macchine, dove c'erano già abbastanza schiavi a prendersi cura di tutto, Omrad decise di vendermi ancora una volta. A quel punto della mia vita ricordo che pensassi che non importasse più tanto, niente poteva essere peggio dei cunicoli e dei forni, che a volte erano ancora così caldi da far attaccare la pelle al ferro e bruciarla viva. Ero entrato così a fondo nella mia routine da schiavo che non esisteva più, nella mia testa, l'idea che un giorno sarei stato libero. Nella lingua di Idur la parola libertà non esiste. O sei un Moos, un uomo, o sei un Kunzaz, uno schiavo. E io non la ricordavo più, com'era la libertà. Erano stati molto meno i miei anni da schiavo che quelli con la mia famiglia, ma per qualche motivo mi sembrava strano ricordare un tempo in cui non ero stato Ath. Tenevo gli occhi bassi, perché al mercato non era permesso a noi schiavi di guardare la folla e se ci chiedevano di alzare il volto perché lo esaminassero dovevamo farlo ad occhi chiusi. Non sapevo cosa fosse quello che a Idur, dispregiativamente, chiamavano Jalzath, ma ricordo benissimo quando l'uomo che mi stava esaminando mi chiese di aprire gli occhi. Non aveva i lineamenti duri tipici degli uomini di Idur, né quell'accento feroce nelle parole, anche se conosceva la lingua di quei luoghi abbastanza da sorridere divertito dagli insulti bofonchiati da Omrad alle mie spalle. Fu la prima volta che vidi A'aq Elmar Asad Al Luqtal. A'aq, su Al Sura, è un titolo molto importante. Esistono molti viaggiatori, ma in pochi riescono ad avere l'onore di essere A'aq o A'iya nella loro vita. La prima cosa che mi chiese, mentre ci allontanavamo dal mercato degli schiavi, fu il mio nome. Gli dissi che ero Ath, ma Elmar Asad mi chiese quale fosse il mio vero nome. Non so dire perché, in quel momento, scelsi Delishk. È parte del nome i mi madre e nella mia lingua Dėlïshk significa "errante, nomade". Forse avevo bisogno di sentirmi vicino alle mie radici, ma ancora così lontano da casa e da tutto quello che conoscevo, non potevo che essere solo un vagante disperso a miglia e anni luce dal mio sangue. Elmar Asad mi portò nella sua città: Hillaj. Ho già detto tanto di Hillaj, ma non dimenticherò mai quel primo momento in cui la vidi da lontano, lì arroccata sulla sua collina a strapiombo sul mare. Ne fui incantato e qualcosa, nel modo docile con cui mi parlava Elmar Asad, mi fece capire che gli incubi di Idur erano lontani. La sua casa si trovava in prossimità della Piazza Alta, a qualche metro di distanza, in basso, sulla strada principale che risaliva tutta la collina da cima a fondo. Ad attenderci nel giardino interno, l'enorme atrio che si apriva subito oltre la porta di legno chiaro, c'era A'iya Saida Zayirah Al Luqtal, la moglie di Elmar Asad. Scoprii solo dopo che Saida Zayirah non poteva avere figli, ma che questo l'aveva portata alla sua vocazione più grande, quella che divideva con Elmar Asad. Avevano guadagnato anche per questo il titolo di A'aq e A'iya, oltre a tutte le altre qualità che in poco tempo mi fecero capire che tutte le regole che avevo imparato come schiavo potevo dimenticarle. Non era facile per un bambino riuscire davvero a scrollarsi quegli anni di dosso, e ormai ne avevo 13 e quei tre anni passati nel silenzio erano ancora saldamente stretti nella mia testa. Elmar Asad e Saida Zayriah erano pazienti e avevano preso altri bambini e ragazzi che, come me, avevano avuto la sfortuna di finire su un mercato di schiavi o l’altro. Era questa la loro missione, o come la chiamavano. Quando potevano prendevano anche uomini adulti, anziani, chiunque riuscivano a strappare dalle mani della schiavitù e li portavano lì, nella loro casa a Hillaj, per concedere loro, o noi, tutta la dignità che ci era stata strappata e, sopratutto, la libertà. Ci chiamavano Nilura in città, e probabilmente in molti erano più gentili solo perché sapevano che eravamo i Nilura dei Al Luqtal. Nilura, nella lingua di Al Sura, significa benedetti. Erano stati gli abitanti di Hillaj a dare questo nome a tutti gli ospiti di quella casa, e sebbene avessi sentito spesso Elmar Asad ripetere con la sua solita voce docile a una persona o l’altra che non eravamo benedetti, ma solo persone che meritavano più di quanto ci avessero dato, nessuno mai smise di usare quel nome per tutto il tempo che rimasi a Hillaj. Compresi che quella casa, in città, era conosciuta come Diyat Meheel, che significa “la casa di luce”. Mi chiedevano spesso, quando ebbi abbastanza coraggio da avventurarmi per tutti i vicoli di Hillaj, di raccontare storie sulla Diyat Meheel e mi resi conto che quella gente aveva una venerazione e un rispetto verso gli Al Luqtal che non aveva limiti. Mi insegnarono tutto quello che conoscevano, ed era molto. Avevano viaggiato per Mondi e Dimensioni, ne avevano raccolto con cura i segreti e ricordo di come nei loro occhi, quando ci radunavamo nelle sere più limpide nel giardino interno accomodati sopra i grandi cuscini colorati, potessi intravedere tutta la bellezza di quello di cui parlavano. Ci trattavano più che bene. Eravamo tutti abituati ad essere schiavi e ricordo che molti di noi, appena arrivati, erano a disagio con l’idea di non fare nulla. In quei casi Saida Zayirah concedeva ad alcuni di noi di fare piccoli lavori insieme agli altri che lavoravano lì. Lavare i piatti dopo pranzo, aiutare a ritirare o stendere i panni, e ogni volta insisteva a darci dei soldi che avremmo potuto usare per tutto quello che volevamo. Non erano mai lavori difficili, ma sia lei che le signore che si prendevano cura di tutto, insistevano che i bambini non avrebbero dovuto fare cose troppo difficili o pericolose, ma imparare e studiare. Ci insegnavano la storia, le arti, la scienza, la cultura, a rispettare la natura e la magia, poiché ad Al Sura la magia era ovunque e in ogni essere e veniva trattata con un rispetto infinito. Alcuni di noi avevano il potere di Viaggiare nelle Dimensioni, ci chiamavano Sehluwa, i Camminatori, e sapevo che tutti noi, segretamente, avevamo il sogno di essere tanto grandi come lo era Elmar Asad e di guadagnare il titolo di A’aq. Imparammo anche a guidare le Jidhab, le Navi dei Cieli. Sono esattamente come navi del mare, con gli scafi in legno che si allungavano in ghirigori tipici dei popoli di Al Sura e le vele dispiegate che catturavano il vento per correre nei cieli. Esistevano, in alcuni punti di Al Sura che venivano solitamente evitati, i famosi Masiyat, i Pirati dei Cieli. Si aggiravano per lo più nelle zone a sud, quelle più calde, lontani da Hillaj, ma ricordo che nel periodo in cui ero lì si parlò a lungo, nel mio secondo anno di permanenza, di un attacco dei Masiyat a Sarul, una delle città mercanti del sud. Era la più vicina a Hillaj, per quello se ne fece un gran parlare, perché i Masiyat non si erano mai avvicinati tanto alla capitale, ma quella volta erano stati così vicini che ricordo che in molti, in quei giorni, continuavano a fissare i cieli come aspettandosi di vedere una prua scura spuntare dalle nuvole. Non accadde mai, ma una volta, quando alcuni di noi viaggiavano con Elmar Asad per raggiungere la città di Haimat, ne vedemmo una. Era quella del Capitano Sabid, e lo sapevamo perché le sue bandiere avevano lo stemma della lama e il serpente, ma per quanto avessimo paura, noi tutti, Elmar Asad era tranquillo. La nave si affiancò alla nostra e ricordo che noi altri ce ne stavamo chiusi in cabina a guardare dagli oblò quello che succedeva, troppo spaventati per fare qualcosa. Quando Elmar Asad prese a parlare, però, mi calmai tanto che mi permisi di uscire e ricordo che mi guardò con un sorriso, muovendo il braccio per farmi vedere dal Capitano Sabid. Fu la prima volta che lo incontrai, ma non l’ultima. Sabid e Elmar Asad si conoscevano da anni, e si erano conosciuti proprio durante uno dei viaggi di Elmar Asad. Sabid aveva un gran rispetto per gli A’aq e le A’iya, per quello non aveva mai osato attaccare nessuno di loro, e così alla fine si erano trovati a parlare e fare parte del viaggio insieme. È una storia che sembra quasi assurda, ma a conoscere come conosco io Elmar Asad si ritrova tutta la sua personalità anche in questo. Sabid lo incontrai tempo dopo, quando a 14 anni dissi a Elmar Asad e Saida Zayirah che avevo intenzione di viaggiare per cercare la mia famiglia. Elmar Asad mi portò fuori città qualche sera dopo, e mi stupii, arrivati nella piccola città di Ahlam, di ritrovarmi lasciato alle cure del Capitano Sabid. Era stato, prima di darsi alla pirateria, un membro delle Serpi di Hillaj. Lui era nato molto più a nord, nei pressi di Al Quwihan, ma da bambino lui e i suoi genitori si erano trasferiti nella capitale. Le Serpi di Hillaj sono un Ordine molto antico, il più antico di Al Sura. Si trattava di combattenti che usavano delle spade tipiche di Hillaj, con le lame leggermente ricurve e mai troppo lunghe. Mi insegnò ogni cosa. La loro filosofia, che riprendeva le movenze da quelle degli elementi, per fondersi con la terra, il cielo, la sabbia, l’erba, il mare e i monti ed essere una mutevolezza che sapeva quando resistere, quando fluire, quando irrigidirsi, quando essere leggero. Siamo rimasti lì per quasi un anno, e alla fine Sabid mi regalò una piccola Jidhab per tornare a casa, e due Manihan, le spade delle Serpi di Hillaj. In quegli anni mi ero fatto un nome a Hillaj. Da quando avevo rivelato che il nome con cui mi facevo chiamare, Delishk, significava errante o nomade, in città, e ovunque andassi, avevano preso a chiamarmi Al Sahi. Al Sahi, nella storia di Dei e Creazione di Al Sura, era l’Eremita, una figura che si dice venisse da molto lontano e che aveva dato vita alle stelle, per permettere a tutti i viandanti di orientarsi con esse. Avevamo viaggiato tanto con Elmar Asad e Saida Zayirah, ma al mio ritorno a Hillaj, quando avevo ormai 15 anni, cominciai a viaggiare anche da solo. Divenni un mentore, un Isuwa che, ad Al Sura, sono gli uomini dei discorsi. È una parola che viene usata per descrivere il ruolo di chi tiene dei comizi. Non ero ancora uscito da Al Sura da solo, ma con Elmar Asad e Saida Zayirah sì e spesso, nei miei comizi, parlavo di questo. Ricordo di quanto fossi felice quando a quasi 16 anni mi dissero che avrei potuto partecipare al A’isad. L’A’isad è un evento molto importante. Si tiene ogni due anni a Hillaj, ed è un evento in cui gli invitati, i Sareef, si sfidano in molte prove fisiche e mentali, di cultura e quant’altro, e tutti, in tutta Al Sura, sanno che tutti gli A’aq e le A’iya sono stati vincitori del A’isad. Non voglio vantarmi, anche se può sembrare così, ma quando venne chiamato il mio nome, Al Sahi, provai un orgoglio immenso. Ma non fu che la sera della mia partenza che Elmar Asad mi diede il simbolo degli A’aq. Era una promessa, mi disse, che il popolo di Al Sura mi aveva strappato, ma lo disse con un sorriso. «So che ne sarai sempre degno» mi disse e non lo dimenticherò mai. Quella sera, mentre salutavo lui e Sadia Zayirah, dissi loro il mio vero nome e il perché avessi invece scelto di essere chiamato in un altro modo quando vennero a prendermi. Saida Zayirah disse che era stato il volere delle stelle che scegliessi proprio quel nome, e che Al Sahi era con me e mi avrebbe guidato nel mio viaggio. Promisi loro di tornare quando sarei riuscito a ritrovare la mia famiglia, ma nel mio viaggio volevo anche incontrare quelli che ad Al Sura chiamano Madin, i Saggi.
Era stato Elmar Asad a parlarmi di Urjec Qahl, così come mi aveva parlato di tutti gli altri Madin che aveva incontrato e quelli di cui, invece, aveva solo sentito parlare. Urjec era originario di una Dimensione che non esisteva più, consumata dall’Oscurità e persa per sempre, ma lui si era stabilito molto tempo prima a Yean Edhil. Per quando ne sapeva Elmar Asad, Urjec abitava ad Allanar e fu lì che andai. Era molto diversa da quello a cui mi ero abituato. Yean Edhil non aveva il clima caldo di Al Sura, né i suoi colori. Aveva una bellezza eterea, con eleganti palazzi in marmo bianco che sbucavano dagli arbusti, o piccole città di legno nascoste nelle foreste. Rimasi ad Allanar poco più di due settimane e chiesi a chiunque di Urjec Qahal e ogni volta mi rispondevano che era partito, ma nessuno sapeva dove fosse andato. A quanto pare non era insolito che Urjec partisse per dei viaggi che potevano durare qualche giorno, ma anche mesi interi. Una volta, mi disse la donna che aveva la casa proprio di fronte a quella di Urjec, era stato via addirittura un anno intero. Erano viaggi che faceva per meditare, per imparare, per isolarsi e riconnettersi alla natura. Questo me lo disse Urjec stesso molto tempo dopo. Riuscii a trovare informazioni in una piccola locanda nascosta dentro un’antica quercia tanto grande da essere un’intera parete del locale. Era di una donna di nome Edea che, da giovane, era stata una delle sue allieve. Mi disse che lo avrei potuto trovare nei pressi di Ne Alari, la città Bianca, e che non sarebbe tornato prima di un paio di settimane. Avevo dovuto lasciare la mia Jidhab ad Hillaj, ma non ci misi molto a trovare qualcuno che mi accompagnasse molto vicino a Ne Alari. A Yean Edhil esistono delle persone che vivono su quelle che sembrano quasi barche, ma hanno delle ruote e vengono trainate da animali che lì vengono chiamati Naevys che, mi spiegò una volta Urjec, è una parola che deriva da altre due unite che sono: Naheri e Vysahal. Naheri è il concetto di un dono fatto da Madre Terra, che loro chiamano Nahani, mentre Vysahal è il concetto dei rami che si intricano fra di loro. Sono creature che assomigliano a cervi, ma molto più grossi, quasi come cavalli, e immagino che il Vysahal si riferisse alle corna delle creature. Queste persone, ad ogni modo, vivono su questi carri erranti, Lanahari, con dei meccanismi di legno che creano delle tende piuttosto comode per dormire. Viaggiai con loro fino al cuore della grande foresta che avvolge in parte Ne Alari, perché, mi spiegò sempre Urjec, sono i Tehel’han, il Popolo delle Foreste. Mi ci vollero altri tre giorni di viaggio per arrivare a intravedere le cime bianche della città, e altri due giorni per riuscire a trovare l’esatto punto in cui si trovava Urjec. A quel punto, ero in viaggio da più di una settimana, e sfioravo le due. Urjec però era ancora lì, appena fuori dalla città, in una casa dello stesso marmo bianco di Ne Alari, ma raggiungibile da un ponte che si sollevava sopra il fiume. Ne Alari, la Città Bianca, era costruita in fatti a ridosso della grande foresta e di un lago, collegato da miriadi di fiumi che venivano usati dalle imbarcazioni per muoversi in tutta Yean Edhil. Urjec era andato in città perché, una volta l’anno, c’era una festa in cui molti Maghi Elementali andavano ad esibirsi e scambiarsi conoscenze e informazioni, ma si era intrattenuto un po’ di più, mi spiegò quando lo vidi per la prima volta, perché la sua allieva, Calien, non era mai stata nella capitale e voleva visitarla. Urjec era molto diverso da Elmar Asad. Era più acceso, non era mai riuscito a perdere del tutto l’accento delle sue terre che gli faceva arrotolare la lingua sulle “r”, e non aveva la calma di Elmar Asad. Non era burbero, ma ricordo di averlo visto arrabbiarsi davvero e sembrava, in quei casi, fatto di fuoco. Ma mi ricordo anche di come quegli occhi, che sapevano sembrare sempre tanto giovani da essere pregni di una luce propria, sapevano riempirsi di una tristezza che non può essere descritta. Ci sono cose, a questo mondo e fra tutti quelli che esistono, che possono essere solo sentite, guardate, assaggiate, provate sulla pelle. Urjec aveva visto l’inizio della fine del suo mondo, e ogni tanto quel peso sapeva alzarsi, nelle sere in cui ce ne stavamo intorno al fuoco solo noi tre, con qualche fruscio che dalla foresta si alzava come se fosse un sospiro che accompagnava le sue parole sempre cariche di tutto. Di tanto in tanto gli piaceva animarle quelle fiamme, dar loro una forma come se fossero attori su un palcoscenico. Urjec adorava il teatro. Ci aveva portati a qualche spettacolo, quelle volte che tornavamo a Ne Alari per un motivo o l’altro, o solo per il piacere di attraversare la Grande Foresta o uno dei versanti dei mille e mille fiumi che portavano alla Città Bianca. Fu dopo una di quelle sere che ci raccontò d cos’era successo al suo mondo e, anche se non lo aveva visto sprofondare, ci disse, lo aveva visto consumarsi poco alla volta. Come se si spegnesse. Le persone, negli ultimi anni, si erano fatte più crudeli, più aspre, arrabbiate, tristi. Era stata una grande terra, la sua, e la chiamavano Ragye. Era cresciuto in una piccola città, Xiantong, e sua madre era stata una delle Sacerdotesse di quei luoghi. Era stata lei a insegnargli quella magia che, come in un ciclo perpetuo, io ero andato ad imparare da lui. Ci disse di come, di tanto in tanto, lei lo portasse lì dove tutto era fatto di elementi, in un mondo a parte dove ogni cosa esisteva per la sua mera natura, ed era così che aveva imparato come esiste un bilancio per ogni cosa. Yin e Yang o, come li chiamava lui, Jenjou e Jragi. Erano l’essenza di tutto ci disse, in una delle lezioni che ci impartiva, e non poteva esistere niente in nessuna terra che non avesse una parte o l’altra. Era sempre l’equilibrio quello che permetteva a tutto di coesistere e fluire, andare avanti senza annichilirsi mai. Penso che già in quei giorni Urjec sapesse cosa stava succedendo anche lì, a Yean Edhil. Non ce lo disse mai chiaramente fino all’ultimo, ma lo aveva scritto negli occhi in ogni sera in cui, per qualche secondo, si perdeva a guardare la sua piccola casa nel lego ad Allanar o le grandi meraviglie naturali che ci circondavano, e con ancora lo sguardo perso sembrava ammirarle come se volesse stringersele così tanto fra le palpebre da non dimenticarle più. Ogni cosa ha il suo tempo, ci diceva spesso, e non ci si deve affannare per risparmiarlo. Non si deve annientar, né lasciar morire, ma solo comprendere quando qualcosa ha raggiunto il suo ciclo finale, e lì lasciarla andare. Erano discorsi complessi, ma in qualche modo, quando era lui a dirli con quella voce che s’impregnava sempre di ogni concetto come se potesse toccarlo ed afferrarlo con le sue stesse mani, sapevo trovare uno spazio, dentro di me, che già lo aveva accolto. Ricordo ancora del giorno in cui, di prima mattina e con ancora i raggi del sole che pigri si alzavano dietro i rami degli alberi illuminando lo spazio di fronte casa sua, dove voleva sempre trovarci a quelle prime ore del mattino, ci guardò con occhi più duri del solito. Fu il giorno in cui ci portò nel posto che la sua gente aveva chiamato Nomutruun. Ci spiegò solo dopo che Nomu, nella sua lingua, voleva dire vita, e che turum rappresentava il posto dove accadono le cose. Nomoturun era, per i popoli dimenticati di Ragye, il flusso stesso dell’esistenza e della vita, la sua rappresentazione, il suo fulcro. È importante che io ricordi queste cose, perché non so, adesso, se Urjec è riuscito a sopravvivere, e non so se altri di quei luoghi sono ancora da qualche parte a raccontare le storie di un mondo sepolto, ma ho imparato da Saida Zayirah quanto sanno essere importanti le storie, sopratutto quelle dimenticate, e quanto possano portare con sé tutti i messaggi e le importanze di vite contratte e distrutte. Quelli di Yean Edhil chiamavano quel luogo Nelamel’Nathari. Per loro era il Luogo degli Spiriti, ed è quello che qui chiamano Caos Elementale. Ho conosciuto molti popoli che veneravano quegli spiriti, in quanto essenze della natura, anche se presuppongo sia perché i Madin che ho cercato, prima di arrivare ad Alco, fossero tutti conoscitori di quel tipo di magia. Ma c’è una cosa che non ho ancora detto, ed è importante proprio adesso. Mia madre Tiârastrįėlïshk è nata da un uomo e una Signora delle Nevi, uno degli spiriti che vivono a Nelamel’Nathari, rendendo lei una creatura che è a metà di quel mondo. Io, che sono nato da lei e ancora da solo un uomo, lontano da quelle terre come da quelle di mia madre, non sono altro che un residuo di quel luogo. Nel Caos Elementale non vedono bene quelli come lei, o come me. E io lo sapevo. Anche Urjec lo sapeva, come sapeva cos’ero io e quali fossero le doti che mi scorrevano nel sangue. Posso dirlo con certezza, e ancora di più da quello che mi disse poco prima di trascinarci lì giù. «C’è sempre chi ci viene contro, Threlasan». Threlasan era il nome con cui avevano iniziato a chiamarmi, Urjec per primo. Nella lingua di quel luogo significava “il Freddo”, e non era altro perché, qualche anno prima ad una delle fiere di Ne Alari, avevo mostrato le mie doti in quello in cui ero più bravo perché mi apparteneva nel profondo. Non era comune vedere ghiaccio o neve in nessuna zona di Yean Edhil, ed il mio nome, che ancora conservavo da quando Elmar Asad melo aveva chiesto quella volta che lasciammo Idur, era troppo complesso da capire. Mi sarei abituato presto ai nomi che mi davano in ogni luogo, ma in quel momento mi riusciva ancora rispondere a tutti quelli che già si accumulavano sulle mie spalle. L’unica che ancora mi chiamava Dėlïshk era Calien, e ho sempre pensato che fosse perché, in qualche modo, comprendesse nel modo in cui pronunciavo quelle lettere quanto per me fosse importante. Ad ogni modo, Urjec sapva quanto quel luogo, per me in particolare, potesse essere ostico. Ma dopo avermi detto quelle parole sfiorò il mio sigillo, guardandomi dritto negli occhi. Me lo chiese in quel momento e non lo dimenticherò mai. «Chi sei? Sei forse Ath?» mi colpì molto, forse perché sapevo di perfettamente di cosa parlasse. Ovviamente, Urjec sapeva tutto di Idur, ne avevamo parlato insieme a Calien in una di quelle sere intorno al fuoco, e in realtà, se ci penso adesso, non sa stupirmi di come, fra tutti i miei nomi, abbia scelto proprio quello toccando il mio sigillo. Ero stato Ath e da qualche parte, lo ero ancora. Ero tanto Ath come sapevo essere Al Sahi, o Threlasan o ancora Dėlïshk. Non ero mai stato capace, fino a quel momento, di togliermi il nero di quel pigmento dalla pelle. Essere schiavi, anche se per così poco, sa cambiare. Avevo parlato poco e nulla per tre anni, mi avevano tolto il mio nome, la mia dinastia, la mia famiglia, e ancora non ero stato capace di riappropriarmene. Non fu facile e non fu bello, anche se appena entrai in quel mondo seppi subito riconoscerne quella bellezza di cui Urjec ci aveva parlato. Diceva spesso, lui, che la bellezza sa essere tremenda, e se prima di quel momento non sapevano essermi tanto chiare le sue parole, una volta dentro Nelamel’Nathari compresi appieno quello che volesse dire con quelle parole, così come tutto il resto che ci aveva insegnato. Ho un ricordo affezionato di Urjec, nonostante le sere in cui bevesse troppo Veriel erano tante e finiva a starnazzare contro le stelle. Il Veriel era un liquore particolarmente forte di Yean Edhil, da quel che so lo distillavano da un fiore particolare che cresceva lì, il Vyhir, insieme al suo nettare, con un processo molto complesso che una volta Edea provò a spiegarmi, ma l’ho dimenticato con il tempo. Il Vyhir, si diceva, era nato da goccia di sudore del Dio Cyvel, il padre del Fuoco, ed era per questo che il suo distillato bruciava tanto. Vorrei essere capace di elogiare quelle terre come meritano, ma non ne è rimasto più nulla. Ho detto già di come Urjec sapesse già cosa stava accadendo. Lo aveva già visto e una mattina, una strana mattina in cui ci lasciò liberi da ogni allenamento, ci disse che «non si sfugge dal Destino». Non penso gli fosse mai passato per la testa di fare qualcosa per impedire quel processo e, conoscendolo, suppongo pensasse fosse solo lo scattare di lancette inclementi su un orologio. A volte mi chiedo, come se fosse il gioco curioso di un bambino, cosa avrebbe fatto Elmar Asad, e non mi stupisco nel pensare che probabilmente anche lui come Urjec avrebbe solo guardato tutto dissiparsi. La verità è che ora so che arrivati ad un certo punto non c’è modo di aggiustare nulla, e che superando una linea invisibile tutto è già andato. Ed è quando inizi a vederlo. Ce ne accorgemmo, io e Calien, che gli alberi morivano e i fiori di primavera non ne volevano sapere di sbocciare. Ne parlammo fra noi, fra una chiacchiera e l’altra, come annotazioni casuali in un contesto che non eravamo in grado di capire. Penso che Urjec non ce lo avesse detto apposta. Penso che lo sapesse che, per come eravamo fatti, avremmo cercato di vincere una battaglia che probabilmente era stata persa molto prima del mio arrivo in quelle terre, e voleva solo che conservassimo tutta quella bellezza nel nostro sguardo. Ad un certo punto, non ricordo neanche come o perché, uno dei due deve aver fatto presente ad Urjec tutte quelle stranezze, di cui ormai anche io ero certo essendo passati tre anni dal mio arrivo in quei luoghi. Lui c guardò per qualche istante prima di spostarlo ancora su ogni cosa che ci circondava come se fossero fotografie che gli portavano, alle labbra, quel tipo di sorriso che sta sempre un po’ dentro una malinconia incurabile. «Le cose, prima o poi, finiscono» ci disse. Ci sembrò una delle sue solite frasi arcane, di quelle che spesso pronunciava e su cui di tanto in tanto ci concentravamo prima di andare a dormire, sperduti fra gli antri nascosti negli arbusti di Allanar. Ma capimmo molto in fretta che quella volta le parole di Urjec erano molto più concrete. La verità è che si pensa che una Dimensione che muore dia più segni, e ancora più vero lo fa, ma siamo non a non rendercene conto. Tutte quelle foreste che deperivano, i fori che non arrivavano, l’aria che si faceva più pesante, le voci di conflitti sempre crescenti, assassinii più frequenti, niente ci allarmò abbastanza da capirlo. Tranne Urjec. Come ho detto, lui sapeva esattamente cosa stava succedendo. Lo avevamo visto spesso, negli ultimi tempi, scivolare fuori casa in piena notte e non tornare se non al sorgere del sole,per i nostri consueti allenamenti. Ma era sempre più cupo, sempre meno energico, come se anche lui, insieme a tutto il resto, si stesse spegnendo. Ce lo disse un pomeriggio, probabilmente quando, contando tutto quello che succedeva, decise che era già arrivato il momento di allontanarci. Sia io che Calien sapevamo dell’esistenza di alcuni gruppi che usavano arti oscure ma, a dirla tutta, non era così strano su Yean Edhil. Non era vista come una cosa del tutto normale come ho visto in altri posti che ho visitato, ma neanche tanto aberrante come succede, ad esempio, in quest’ultimo porto in cui sono approdato. Su Yean Edhil li chiamano Neyailgan. Neya, nella loro lingua, è il buio. Non quello della notte, mi disse Calien, quello che Atvel gettò sul mondo per dieci cicli di Luna. Atvel è il Padre dei Cieli, quello che insieme a Milya, la Madre dei Fati, rappresenta il governo di tutto quello che esiste Ioranni, una parola che grossolanamente possiamo tradurre con “al di sopra” nel senso più letterale. Neya non era solo il buio, era quell’oscurità che prosciuga la terra per renderla arida, i fiumi per farli diventare solo gocce frenetiche che non sanno stare in superficie. Neya è anche la parola che, nel tempo, a Yean Edhil è diventata sinonimo di maledizione. Ilgan significa passi, passi ripetuti nello specifico. È una parola che nasce dai cacciatori che seguono le tracce degli animali, ed è questo che rappresenta nella sua forma più pura. Nel senso più popolare, lo stesso che ha coniato la parola Neyailgan, Ilgan è qualcuno che non si guarda intorno, non si premura di controllare quello che accade, ma continua dritto seguendo delle tracce precise. Da questo si capisce che non fosse vista positivamente, la Magia Corrotta, ma ancora una volta non era così strana. Non c’erano leggi, a Yean Edhil, che ne vietassero l’utilizzo. Ad ogni modo, qualcosa doveva essere successo. Noi, così impegnati nel nostro addestramento, ce n’eravamo a stento resi conto, ma Urjec ce lo disse quel famoso giorno, proprio mentre eravamo quasi al nostro stremo. Era la fine per Yean Edhil. Ricordo che guardò a lungo Calien mentre parlava di come quella terra, la sua terra, avesse raggiunto la fine del suo tempo, e che presto, così tanto presto, sarebbe stata consumata come lo era stata quella di Urjec prima ancora. È una sensazione che io non potrò mai descrivere davvero e, a pensarci adesso, vorrei poter chiedere a Calien di dirlo per me, di tramandarlo ancora ed ancora perché non si arrivi più a tanto. Ma è rimasta solo la mia voce, e so che non è abbastanza. Urjec, dopo aver parlato con lei,guardò me e ancora oggi sono certo di quello che mi stesse dicendo. Quello che proferì davvero fu «Il tempo. Il tempo si accartoccia e muore mentre sta nascendo» quello che seppi io, con un’immediata consapevolezza, era che dovevamo andarcene. Urjec non ne volle sapere di seguirci. Ci disse che noi dovevamo andare, ma che lui aveva ancora da fare. In quel momento pensai a Edea e a tutte le persone che conosceva lì, ma oggi, a distanza di anni, posso forse dire che Urjec era sopravvissuto alla fine di un mondo, e non aveva intenzione di sopravviverne ad una seconda. Quando ci penso, e lo faccio spesso, so immaginarmelo nella piccola radura appena oltre i confini del centro abitato di Allanar, seduto con le gambe incrociate e gli occhi chiusi ad ascoltare ogni suono della natura. Ci sapeva stare ore, distraendosi solo quando io e Calien, distratti, ci sapevamo perdere fra mille parole. «Ascoltate», ci diceva sempre, «non voi, ma tutto il resto. Ha qualcosa da dirvi, e vale la pena prestare orecchio.»
Yean Edhil la lasciai con una sensazione diversa rispetto a quella con cui avevo lasciato Al Sura. Non avevo speranza, non così tanta, e ancora oggi il pensiero ce lì, in quel luogo meraviglioso di alberi e marmo chiaro, non è rimasto altro che un antro scuro, ancora mi angustia. Non riesco a pensare davvero al “corso del tempo”, ma solo a quanto sia andato perduto. Era una terra fantastica, e il pensiero che nessuno più potrà vederla, fra tutti i suoi fiumi, le sue feste che smuovevano ogni elemento nell’aia per farne uno spettacolo, mi sa pugnalare il cuore. Eravamo rimasti solo io e Calien. Eravamo entrambi senza una casa, senza un luogo, con nomi dispersi nel cosmo a portare significati che solo noi, nel nostro piccolo, avremmo potuto ricordare. Io tornai ad essere solo Dėlïshk, il nomade. Viaggiammo per un po’ senza meta. Sapevo di volerle dare, in quei giorni così cupi, qualcosa a cui aggrapparsi, farle vedere come ancora, nonostante tutto, il Multiverso avesse delle bellezze nascoste che non erano state distrutte. A Hillaj esisteva un motto che diceva così: Araz Al Hamad Saleb Mashaf, non so il significato preciso di ogni parola, ma Saida Zayirah mi aveva spiegato che nel suo senso rappresentava il sole che sorge dopo le notti più cupe, la luce del faro che sbuca nelle tempeste, le luci refrattarie piene di colori quando la pioggia scema e il sole colpisce le gocce che restano. Lo ripetei tante volte a Calien in quei gorni, quelle settimane e quei mesi. Araz Al Hamad Saleb Mashaf al mattino, Araz Al Hamad Saleb Mashaf ad ogni paso, Araz Al Hamad Saleb Mashaf ogni sera, prima di addormentarci. Non provai a tornare a Allanar, o nel Yean Edhil neanche quando me lo chiese con tanta forza che seppi sentirla mia quella disperazione bisognosa delle sue terre, quelle dove le sue radici erano nate e cresciute. Le raccontai invece di Esålengræknüčak Tiârastrįėlïshk Hölasdot-Varlas, e di tutto quello che ricordavo di mia madre, mio padre, mia sorella. Le raccontai di tutto quello che era stato prima che ci fosse Ath, prima di Dėlïshk, prima di Al Sahi.
Quando arrivammo a Kirn Nardirth erano ormai passati cinque mesi. Avevamo visitato altri luoghi, girovagando per lo più senza meta. Avevo parlato molto della mia famiglia in quei tempi, e Calien, una sera, mentre eravamo stesi sull’erba viola di un pianeta con tante lune da sembrare un anello intorno al mondo, mi disse una cosa che non credo dimenticherò mai. «Siamo uguali, io e te, adesso» mi resi conto che aveva ragione. Fu naturale decidere di restare insieme, anche senza dircelo mai, e quando arrivammo a Krin Nardirith come dicevo, cinque mesi dopo essere fuggiti, sapeva già perché ci eravamo spinti in quella terra di vapore e sabbia. Le avevo raccontato, a quel punto, molto anche di Hillaj e dei Madin e ne avevamo anche incontrato qualcuno lungo quel breve pellegrinaggio. Sapeva di Alco quando ci avvicinammo alla grande città di lamiere per trovare la sua bottega fra luci al neon e rumori di parole conciate. Nam Dural non aveva niente a che fare con le città in cui mi ero stabilito in quegli anni. Immagino che erroneamente, all’inizio, con tutte quele volute dense che si alzavano verso il cielo, avessi pensato che era una città come Idur, ma mi sbagliavo. Avevano imparato a fare molto con la magia, usandola sopratutto in modo meccanico per creare congegni che, quando iniziai a studiarli con Alco, nella sua officina, mi lasciarono affascinato. Alco ci raccontò molto di Krin Nardirith e della sua storia. Anni e anni prima, addirittura, forse, qualche secolo, era stato un pianeta ricco e verde, ma gli uomini si erano fatti avari, avevano lottato fra loro finché non avevano raso al suolo tutto, inaridito la terra e distrutto ogni cosa. Non restava che una società che ancora si stava costruendo da capo, e quelle macchine che volavano nei cieli sbuffando pigre. C’era, a Nam Dural, un giardino protetto da delle barriere speciali, Alco ci portò a vederlo ma ci disse che non si poteva entrare a meno che non si era addetti ai lavori. Era molto importante, ci spiegò, perché non solo erano così poche le piante che servivano per dare ossigeno al mondo, ma anche perché era lì che si faceva da mangiare e senza quello sarebbero tutti morti di fame. Alco parlava poco di tante cose e sembrava sciogliersi solo quando si trattava di storia o fatti dei suoi luoghi. Ci raccontò delle corse nel deserto. Un paio di mesi dopo il nostro arrivo, Alco, che dovrei menzionare aveva una gamba e un braccio interamente fatti di metallo, prese a lavorare strenuamente ad una delle sue macchine e, quando qualcuno passava e si metteva a parlare con lui, e parlare direi è un complimento dato che rispondeva solo con qualche mugugno, avevamo sentito menzionare una certa corsa. Quella stessa sera Alco ci spiegò che non c’era molto da fare in quei posti e che tutto, più o meno, girava intorno ai motori. Così, una volta all’anno, non si sapeva come o perché o quando fosse iniziata, si gareggiava nel deserto, in uno dei canyon che se ne stavano a sud di Nam Dural. Tutti i meccanici partecipavano, cercando di costruire la macchina migliore. Sarebbe stata di lì a qualche mese. A quel punto io e Calien pensammo di imparare a guidare quei marchingegni. Alco non poteva aiutarci, troppo impegnato alla sua officina, ma Catch, che era la sorella di Alco, venne con noi giù fino al canyon e ci spigò come guidarle. Loro li chiamavano Gar Ulum e fu proprio Catch, quella volta, a spiegarci che ad un certo punto il loro popolo si era trovato senza più niente, neanche un libro, e che quando c’era stata la Grande Carestia molte etnie diverse si erano unite. La maggior parte delle parole che usavano era del tutto inventata, qualcuno aveva ad un certo punto puntato qualcosa e lo aveva nominato in una lingua che un altro non conosceva, la pronuncia era cambiata di bocca in bocca, e così erano nate tutte le loro parole. Ad ogni modo, Catch ci spiegò come si guidava un Gar Ulum ed era decisamente diverso da una Jidhab. Devo ammettere che se io non ero poi tanto bravo, Calien al contrario sembrava portata per quelle macchne. Probabilmente fu per questo, e per Catch, che alla fine alla corsa Alco chiese a lei di guidare la sua Gar Ulum. Fu proprio da dopo la corsa che la gente a Nam Dural iniziò a chiamarla Bird. Era stato Alco a spiegarci come funzionavano i nomi lì. Nessuno si chiamava mai in nessun modo, in un certo senso, ma a tutti veniva affibbiato, poi, un nomignolo. Per quanto riguarda la corsa ricordo che ci fu un gran muoversi. Tutta la gente di Nam Dural si era riversata al canyon, e in molti avevano portato i loro banchi di cibo e bevande sopra quelle altre macchine, quelle che solcavano la sabbia e che venivano chiamate Vurgrum. Alcune Vurgrum erano davvero enormi, delle dimensioni di un camion, altre erano piccole e sgusciavano rapidissime sulla sabbia. Quella volta, cal canyon, sembrò una gran festa. Dopo le corse si usava restare fino a notte fonda lì, con le luci dei Vurgrum e dei Gar Ulum ad illuminare tutto mentre qualcuno alzava la musica che batteva contro gli amplificatori e si diffondeva ovunque. Era una musica molto metallica, quella di Krin Nardirith. Alla gara Calien arrivò terza che, come le disse Alco quando scese dal Gar Ulum, era assolutamente strabiliante, e giuro che usò proprio queste parole, visto che aveva da poco imparato a guidarli. Restammo lì a far festa, anche se dopo un po’ io e Calien decidemmo di tornare all’officina. Cath ci fece usare la sua Vurgum e, ovviamente, fu Calien a guidarla. Quando tornammo nella città era deserta. Le luci erano accese, così dal deserto Nam Dural sembrava un’enorme conglomerato di luci e lì, fra le sue strade strette e quelle luci forti, mi diede un senso che ancora oggi non so descrivere. Dicevo molte cose strane, a quei tempi. Non so perché, forse per tutto quello che era successo, ma capitava spesso che me ne uscissi con qualcosa di particolarmente criptico sulla sensazione che mi davano le cose. Penso che fosse per quello che mi chiamavano Omen, insieme al fatto che il mio sigillo, che una volta dei bambini avevano visto riempendomi di domande, assomigliava a quello che era inciso sull’unico tempio che era rimasto in piedi dopo la Grande Carestia. Dovrei dire, forse, che a Nam Dural avevano in effetti una Divinità. Una sola, a differenza dei posti in cui ero stato. Nessuno sapeva come si chiamasse davvero, e nessuno ricordava la sua storia, ma la chiamavano Hintoduhr. Quello che veneravano era il simbolo di un occhio inciso su un pezzo di pietra. Con gli anni anche il tempio era stato aggiustato con delle lamiere, ma quell’unico pezzo di pietra non era stato mai toccato. Portava male, dicevano, toccarlo. Era la casa di Hintoduhr, ed era da lì che guardava il mondo. Ad ogni modo, quella volta, quando tornammo in città, decidemmo di non tornare subito a casa. Penso volessimo vivere la città vuota, e vi assicuro che è un’esperienza tanto strada quanto rinvigorente. Abbiamo fatto su e giù per la strada principale, ci siamo spostati nei vicoli camminando a testa in sù per guardare tutte le luci di Nam Dural. Da lontano potevamo sentire ancora il rimbombare della musica e, a quella distanza, sembrava quasi il battere ritmico di pezzi di metallo che si scontravano ancora ed ancora. Calien, quella sera, mi chiese se ci saremmo mai fermati. Lo chiese in un modo che mi fece capire che non parlava davvero del viaggiare o meno, ma di trovare un luogo che ci avrebbe fatto sentire a casa. Non sapevo cosa risponderle, ma le dissi che non lo sapevo. Quella sera, ormai tornati a casa e seduti fuori al piccolo terrazzo proprio sopra l’officina, con i piedi che ballavano nel vuoto e quella strana e lontana musica in sottofondo, le diedi un nome. Ïldrît nella mia lingua vuol dire speranza. Perché adesso eravamo uguali, io e lei, e se io avevo un nome che veniva dalle sue terre, anche lei ne avrebbe avuto uno che veniva dalle mie.
Non restammo molto a Krin Nardirith. Otto mesi dopo il nostro arrivo eravamo già pronti a ripartire. Era passato poco più di un anno dal nostro saluto con Urjec e, ormai, avevamo smesso di chiederci se lo avremmo mai più incontrato. Penso che, in cuor nostro, lo sapessimo e, semplicemente, non ci fosse bisogno di parlarne. Quando salutammo Alco e Catch ci regalarono due bracciali fatti con delle vecchie rotelle di ingranaggi. Ne avevamo visti spesso di simili, durante quei mesi, ed era un po’ così che funzionava la moda lì. Quando lasciammo Krin Nardirith sapevamo entrambi di non avere, ancora una volta, nessuna meta. Girammo ancora per tanti e tanti posti, cercando la mia famiglia e raccogliendo ogni sorta di storia e testimonianza. Avevamo conosciuto tante persone in quei viaggi, e spesso pensai che saremmo potuti andare a Hillaj. Lo dissi anche a Calien, una sera in cui eravamo seduti in una piccola locanda di un luogo sperduto, di quelli in cui andavamo quando non avevamo tanta voglia di essere circondati da troppe persone. Lei mi guardò e mi chiese se, tornando lì, avevo intenzione di andarmene di nuovo. Ricordo quanto fui sorpreso di non essermi accorto prima di quel momento di quanto avesse ragione. Volevo andare a Hillaj non per prendere una pausa, ma per restare. Alla fine eravamo solo stanchi. Me ne resi conto con una precisione sconcertante, mentre un silenzio leggero scendeva fra di noi. Mi resi conto che anche se non aveva detto nulla, Calien mi aveva posto una scelta. Potevamo fermarci. Potevamo andare a Hillaj proprio in quel momento, pensare alla vita sedimentaria in un posto solo. Pensai a quella vita. Ci pensai a lungo in quei pochi secondi. Pensai a Elmar Asad e Saida Zayirah, a Sabid, alla mia Jidhab, alla fontana nella Piazza Alta. Hillaj sarebbe piaciuta a Calien, come tutta Al Sura. Avremmo potuto viaggiare, di tanto in tanto, sopra la mia Jidhab e vedere tutti i posti più belli che neanche io, ancora, avevo visitato e poi, sempre, tornare a casa. Era quello che volevamo entrambi e lo sapevamo. Un posto, uno qualunque, che ci accogliesse come suoi figli e non ci facesse sentire più così spersi ovunque. La casa di Calien non esisteva più e neanche la mia. Pensai davvero di dirle di sì, ma quando mi girai a guardarla di nuovo aveva quel sorriso tiepido e quegli occhi accesi come due stelle nel cielo scuro. Lo sapeva già, Calien, che per quanto volessi dire quel sì, non ero capace di farlo. Non era il viaggiare, era il cercare. Proprio come aveva detto Saida Zayirah, qualche sera prima che me ne andassi da Hillaj. Non avrei mai smesso di cercare la mia famiglia. Le chiesi, allora, se lei volesse andarci. Avrei potuto portarla ad Al Sura, in quella casa che aveva ospitato anche me per anni, e continuare a cercare senza smettere mai. Mi chiese il mio nome. All’epoca, sapeva che tutti quelli che avevo usato, a cui avevo mai risposto, non erano il mio. Glielo dissi, glielo spiegai in tutti i suoi sensi, lettera per lettera, mentre lei, paziente, guardava da me alle stelle, come aspettandosi di trovarlo scritto lì qualcosa che a me sfuggiva. «Nüčak» mi disse «sembra il presagio di una vita». Mi guardò ancora in quel modo con cui mi guardava ogni tanto, come se conoscesse qualcosa che io, ancora, non sapevo. «Araz Al Hamad Saleb Mashaf. Mi hai chiamato Ïldrît, e io ti ruberò Nüčak, Esålengræk» vorrei poter tornare a quella sera. Vorrei farlo con tutto quello che ho. Premere quel sì tanto forte da far tremare la terra. Se fossimo andati a Hillaj niente di quello che stava per accadere sarebbe successo. Potremmo essere da qualche parte, ora. Magari in una delle città portuali del sud, a guardare il cielo in attesa di vedere uno scafo scuro sbucare dalle nuvole. Avremmo lavorato da Elmar Asad e Saida Zayirah, avremmo potuto istruire i bambini della Diyat Meheel. Ma decidemmo di andare avanti. Ricordo che la sera in cui Saida Zayirah mi raccontò per l’ultima volta la storia di Sharji,il ragazzo che andò a cercare i suoi ricordi in un buco nel cielo, mi disse una cosa molto importante. «A volte per trovare qualcosa di cui hai bisogno perdi qualcos’altro» nella storia, Sharji riesce a trovare i suoi ricordi, ma Al Aduraq si arrabbia tanto di aver perso la scommessa che lo punisce accecandolo per sempre. Non andammo mai ad Al Sura, e posso solo immaginare di parlare a Calien della storia delle due Lune, Adlaj e Sehlul, guardandole quando entrambe sono alte nel cielo e tanto vicine da sembrare si stiano sfiorando.
Di quella dimensione ne sapemmo quasi per caso. Ne avevamo sentito parlare da un A’aq che avevamo incontrato durante il nostro pellegrinare. Ci disse, in realtà, che se ne parlava molto fra gli A’aq e le A’iya. Sentivamo tutti di avere un compito, noi con il sigillo, e sapevo mentre ne parlavamo con Ilyad, era questo il nome dell’A’aq, che anche io sarei dovuto andare lì. Ilyad ci offrì un posto dove trascorrere qualche giorno, e noi accettammo. Ne parali con Calien. Da quello che ci aveva detto Ilyad era un posto pericoloso e ricordo che ci guardò in un modo specifico, quello in cui si contano gli anni trascorsi di qualcuno e quanti ancora ce ne dovrebbero essere. Avevo già deciso, e forse era solo perché quel titolo, A’aq, mi faceva sentire in dovere, o forse solo perché a sentire di quelle storie non ero capace di fingere che non esistesse quando sapevo che, anche se poco, potevo aiutare. Ilyad mi spiegò che molti di noi stavano andando a Neurosis appena potevano, cercando di portare via quanta più gente riuscissero per toglierli dalle mani dell’Impero. Neurosis, era così che si chiamava quel posto. Ne parlerò per spiegare perché fosse così cruciale quello che le A’iya e gli A’aq stavano cercando di fare lì. Era una terra divisa in due, da un lato c’era, appunto, Neurosis con le sue tecnologie e i suoi palazzi di vetro, scuri e alti svettavano come dita contro il cielo, quasi volessero afferrarlo; dall’altro lato c’erano invece i popoli antichi, con le loro città chiare e in armonia con la natura. Era successo che ad un certo punto qualcuno aveva scoperto che la magia era una fonte d’energia, così era iniziata una guerra e così Neurosis stava sterminando tutti quei popoli. Detto questo, noi A’aq e A’iya aiutavamo proprio quei popoli a sfuggire. Ilyad mi disse che alcuni li portavano a Perel, che è un posto che è quasi un porto per chi, come noi, Viaggia nei Mondi. Anche io e Calien ci eravamo stati, anche se per poco. Gli chiesi se sapesse qualcosa di A'aq Elmar Asad Al Luqtal e A'iya Saida Zayirah Al Luqtal e mi disse che li conosceva. Sapeva per certo, Ilyad, che loro erano stati già lì e avevano portato qualcuno a Perel, qualcun altro ad Al Sura. Quando ne parlai con Calien le dissi che sarei andato da solo. «Nüčak» mi ripeté, guardandomi con tanta forza che seppi che ogni mia parola sarebbe stata inutile. Non andammo subito lì una volta lasciata la casa di Ilyad, perché lui ci consigliò di andare prima da A’iya Quile Do’sek che, a quanto diceva lui, era stata la prima ad andarci e ad avere più informazioni di tutti. La trovammo proprio a Perel e discutemmo a lungo. Ci spiegò dove andare, come funzionavano le cose, cosa evitare. Era molto informata sull’andamento della guerra, e sapeva perfettamente quanto si fosse spostato il confine. Aveva un’espressione molto stanca, ma ricordo anche quanta forza potevo vedere in quegli occhi, sopra il volto scavato e provato. Era stata lì già molte volte, ed era un po’ a lei che tutti facevano riferimento per quella storia. Di A’iya Quile Do’sek avevo sentito parlare moltissimo quando ero a Hillaj, e lei mi sorrise quando le dissi che ero stato nella Diyat Meheel. Mi disse di come, quando era molto più giovane e Elmar Asad era poco più che un ragazzo, era stata la sua maestra. Non restammo a parlare troppo con lei, anche se mi fece promettere di tornare a Perel. Alla fine, ci andammo. Io e Calien e ricordo di come, una volta lì, fui felice che avesse deciso di venire anche lei. Non so come descrivere quello che vidi, quello che sentii quando arrivammo lì la prima volta. Sembrava un incubo. C’era una distruzione che faceva male, lo faceva al petto e alla pelle, aveva un sapore così sbagliato sulla lingua. Ricordo di come, ogni volta che tornavamo e vedevamo un posto nuovo, mi sforzassi di immaginare come dovesse essere prima, in tutta la sua bellezza. Spostavo le macerie con la mente, raccoglievo i cadaveri che stavano a terra e li rianimavo nel quotidiano di quello che un tempo, doveva essere stato un posto bellissimo. Non erano mai dei bei viaggi. Riuscimmo a farne abbastanza, io e Calien, andata e ritorno, con tappa sempre a Perel. Quando ci dissero che A’iya Quile Do’sek era morta rimasi a lungo a fissare un punto imprecisato del muro. Non l’avevo conosciuta molto, erano passati poco più di tre mesi da quando avevamo parlato la prima volta, ma mi colpì ugualmente. Anche per Calien era così, e ricordo che per qualche momento nessuno dei due disse niente, limitandoci a starcene seduti fianco a fianco con respiri pesanti che scivolavano dalle labbra. Fu poco prima dell’ultima volta che andammo a Neurosis.
Senza le indicazioni di A’iya Quile Do’sek, che era una delle più brave nella furtività necessaria a raccogliere le informazioni -era stata quella che il suo popolo chiamava Shurrynna, ce lo disse Laric che era suo allievo, che era un titolo che nella sua lingua voleva dire sposa delle ombre- era più difficile muoversi. Ne parlammo a lungo, noi A’aq e A’iya radunati a Perel, e non avevamo molte soluzioni. Sapevamo dov’era andata e deducemmo, da quello, che la linea nemica doveva essersi spinta molto più in là. Rimasi a riposo per qualche giorno, visto che questo tipo di viaggi, e fatti con tanta frequenza, sanno essere debilitanti, ma quattro giorni dopo la morte di A’iya Quile Do’sek eravamo di nuovo pronti a partire.
Me ne pento. Né io, né Calien eravamo davvero in condizioni di andare. Eravamo stanchi, provati, affaticati. Lo sapevo io come lo sapeva lei, ma per qualche motivo non ci parve una situazione così grave, la nostra, da essere un impedimento. Forse, se fosse stato qualunque altro momento, se fosse stata come qualunque altra delle volte in cui già eravamo stati lì, sarebbe stato vero, ma la verità è che stavamo saltando nel buio. Letteralmente. Siamo stati sfortunati. Ci trovammo proprio nel mezzo di tutto e anche per questo, come per tante cose, riesco a ricordare nitidamente cosa accadde subito prima e subito dopo. È curioso pensare come basti un solo secondo. Uno e basta. Né di più, né di meno. È bastato un secondo, quella volta di tanti anni fa, per strapparmi via da tutto e farmi iniziare un viaggio che mi ha portato così lontano, ed è bastato un un secondo a Calien per morire. Un attimo prima mi aveva stretto per il braccio, mi aveva strattonato con forza per farmi evitare un colpo. Mi aveva sorriso e si era girata. Un attimo dopo era accasciata a terra.
La riportai a Perel insieme a quei pochi rifugiati che ero riuscito a mettere in salvo.
Ho pianto per giorni.
Quando riemersi dalla stanza che mi avevano dato Laric mi aspettava nella piazza proprio fuori dall’edificio. Ricordo che mi guardò senza dire nulla e mi accompagnò fino al palazzo che era stata la casa di A’iya Quile Do’sek e che avevamo usato, in tutto quel tempo, come una specie di sede centrale. Avevamo continuato a farlo anche dopo la sua morte, e avrebbero continuato ad usarlo. Avrebbero. Ero stanco. Arrivato a quel punto ero solo stanco, volevo tornare a Hillaj e chiudere tutto, ma quello che non mi aspettavo di vedere, entrando nel salotto in cui ero già entrato tante e tante volta, erano A'aq Elmar Asad Al Luqtal e A'iya Saida Zayirah Al Luqtal. Ricordo che piansi ancora, e lo feci così tanto che Elmar Asad dovette farmi sedere sostenendomi con forza per non farmi cadere a terra. Non mi importava, in quel momento, di chi ci fosse oltre a noi in quella stanza, avevo perso Calien, avevo perso Bird, avevo perso Ïldrît. Ed era davvero così, era la speranza quella che mi mancava. Parlai a lungo con Elmar Asad e Saida Zayirah. Mi chiesero solo alla fine, dopo ore, cosa dovevamo fare con il corpo di Calien. Quello lo sapevo. Conoscevo i riti funebri di Yean Edhil, quelli che erano stati i suoi e pensai che se anche non poteva tornare a quelle terre, forse avrebbe potuto farlo il suo spirito. Li celebrammo il giorno dopo, in una delle zone boscose di Perel. Ricordo di averci messo molto di più a realizzare che non l’avrei vista mai più. È un pensiero strano, va e viene come le onde del male. A volte è così intenso che non sai scordartene, e preme con la forza di tsunami che abbattono tutto, altre è più lieve, si ritira e ti fa sembrare naturale aspettarti di rivedere quella persona da un momento all’altro. Non tornai a Hillaj quando, due settimane dopo, Elmar Asad e Saida Zayirah lasciarono Perel. Parlai con lei ancora una volta, una sera di silenzio in cui, radunati sul terrazzo di quella casa, piangevamo tutti i nostri caduti. Saida Zayirah mi disse, come sempre, una cosa importante. È una donna di una saggezza infinita, tanto che a volte, da ragazzino, avevo pensato che avesse il potere di guardare attraverso tutto e cogliere l’essenza di ogni cosa. Mi disse che i «viaggi non finiscono quando si vede il mare». Può sembrare una frase da niente, quasi banale, ma in quel momento avevo bisogno di quello. Ad Al Sura, quando qualcuno muore, diventa una stella. Dicono così. E nella morte, allora, il proprio nome cambia. Caleem. L’avrebbero chiamata così a Hillaj la stella di Calien.
Dovevo di nuovo andare e mai, come quella volta, mi sentii davvero Nüčak. Ripensai a come fosse stata proprio Calien a dirmi di come quel nome sembrasse un presagio. Esisteva solo un posto che sapeva venirmi in mente. Della mia famiglia ne sapevo quanto ne avevo saputo quando ero stato a Idur, Urjec probabilmente si era condannato ad un destino oscuro, Hillaj era sempre più una terra promessa a cui non potevo ancora fare ritorno, Calien era morta e non c’era più nessuno. In quegli anni, però, avevo conosciuto un’altra anima legata a quella di Calien. Ad Al Sura li chiamano Dumaj Hilat che vuol dire flusso che echeggia, qui, dove mi sembra che ogni nome sia solo l’utilità di una parola, sono Doppi. È così che sono arrivato qui. Ancora non sono Esålengræknüčak. Come non sono Ath, non sono Al Sahi, Threlasan, Omen. Non sono neanche Minylath, il caduto, così come tutti quei profughi a Perel, mi hanno iniziato a chiamare negli ultimi giorni, e poi settimane, e poi un mese intero. Non sono Nüčak, perché l’ho promesso, ma non sono neanche Lengræk, quando non sono guida per nessuno. Sono solo Eså, la luce che si riflette nei cieli più freddi e che sembra, sempre, non avere né un inizio né una fine.
Edited by usul; - 9/12/2022, 01:25. -
.Hai finito!Benvenuto a Brakebills!Ora sei ufficialmente un membro di Brakebills! La prima cosa che devi fare è inserire la pietra nell'inventario [è obbligatoria per poter partecipare a lezioni e quest] e comunica che la tua scheda è stata accettata e che quindi il prestavolto non è più prenotato ma IN USO, qui. Se è il tuo primo pg, ricordati di aggiungerlo nel censimento così verrai spostato nel gruppo Students. In seguito aggiungi il Libretto degli Incantesimi che poi trovare nel regolamento studenti, è molto importante perché altrimenti non potrai partecipare a quest o lezioni. Dovrai tenerlo aggiornato!
Se il tuo PG è un Adulto ricorda di controllare regolamento degli adulti.
Poi controlla nella bacheca se ci sono eventi in corso, potrai subito partecipare, oppure cerca qualcuno con cui ruolare in questo topic o sul gruppo di Facebook.
Per i Maghi Neri/Necromanti il catalizzatore è sempre d'Onice, ma bisogna scegliere l'animale Totem. e ricordati che, nel caso il tuo pg sia uno studente, devi iscriverti correttamente nel Circolo di New York
Ricordati di inserire il banner del GDR in firma!
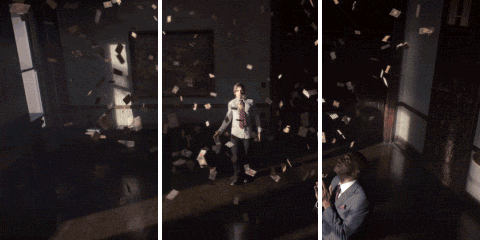 .
.




